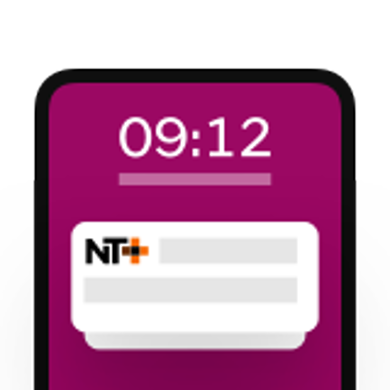Gli investimenti fermi e la tela di Penelope: quei 20 miliardi persi
Per cinque anni i governi di centro-sinistra hanno promesso un’accelerazione degli investimenti pubblici che non è arrivata. Dal 2014 si è annunciato che la ripresa degli investimenti avrebbe trainato l’accelerazione del Pil ma il rapporto investimenti/Pil non ha mai superato la soglia del 2%. Non è mancato l’impegno, soprattutto nel reperire le risorse (83 miliardi in 15 anni con il nuovo «fondo investimenti» di Palazzo Chigi), ma i risultati concreti in termini di spesa effettiva non si sono visti (se si fa eccezione per gli investimenti ferroviari) e a trainare la ripresa sono stati piuttosto export e investimenti privati. Non serve, ora, appellarsi alla ripresa dei bandi di gara del 2018 e proporla come ripresa di mercato: la spesa effettiva non è ancora ripartita e un altro anno si è perso. La flessibilità acquisita a Bruxelles nel 2016 (5 miliardi) è stata utilizzata per spese correnti della Pa che non sono mai state frenate. Ora il rischio serio è di perdere anche il treno per il 2019 e il 2020.
Le incognite 2019 e 2020
I litigi di Genova che frenano la ricostruzione, l’ennesima occasione di sviluppo persa con la rinuncia alle Olimpiadi 2026, la spesa dei fondi Ue ferma al 9%, difficoltà persistenti degli enti locali a investire, l’ennesimo esame con analisi costi-benefici di programmi di opere in corso in una infinita tela di Penelope, che è partito dalla Torino-Lione ma si è poi estesa a tutte le grandi opere (che in questi anni hanno comunque “tirato” sul piano della cassa), la sentenza della Consulta che costringe a rivedere d’intesa con le Regioni le destinazioni del «fondo investimenti», l’annuncio (senza ancora decisioni) della riforma del codice degli appalti in una situazione di quasi-paralisi della Pa sono tutti segnali che potrebbe ripetersi la storia di annunci cui non seguono fatti. Anche se bisogna attendere le prime decisioni vere - quelle della legge di bilancio e sui programmi delle grandi opere - prima di dare una valutazione compiuta.
L’obiettivo del 3%
Ieri il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si è detto fiducioso e ha rilanciato un mantra che già è stato del suo predecessore, Pier Carlo Padoan. «Bisogna accelerare gli investimenti pubblici, portarli al 3% del Pil». Se oggi a consuntivo non arriviamo al 2% mancano quasi 20 miliardi di spesa di investimenti l’anno per centrare l’obiettivo.
Il piano Ance
L’Ance ha contato 300 opere per 27 miliardi che si potrebbero mettere subito in moto con una drastica semplificazione delle procedure. Ci sono scuole da rifare, gestioni idriche da migliorare, dissesto idrogeologico da prevenire, città da riqualificare e infrastrutturare e, ovviamente, le grandi e piccole opere di collegamento ferroviario e stradale. Secondo l’associazione dei costruttori riattivare 20 miliardi comporterebbe la creazione di 330mila posti di lavoro e 75 miliardi di ricadute sull’economia. Certo è che se si vuole dare una vera accelerazione agli investimenti già l’anno prossimo bisognerebbe dare benzina a ciò che è in corso (e non congelarlo) e varare subito un piano di urgenze da cantierare immediatamente.
I tempi burocratici
A bloccare la ripresa degli investimenti pubblici - dopo un decennio di riduzione dei fondi pubblici fino al 2015 - non è stata la disponibilità di risorse, che sulla carta sono andate aumentando negli ultimi tre anni (anche grazie al nuovo «fondo investimenti») e che hanno consentito sempre a Tria di dire recentemente che ci sono già contabilizzati nel bilancio dello Stato 150miliardi spendibili.
A bloccare la ripresa degli investimenti è piuttosto il grande male italiano, con le sue due facce. La prima è una burocrazia che spreca il 54% degli abnormi tempi necessari per realizzare un'opera (mediamente 15 anni) in “tempi di attraversamento”, vale a dire una serie di innumerevoli passaggi e ostacoli creati all’epoca del consociativismo e delle politiche di rigore di bilancio per non fare più che per fare. A stimare questi tempi è uno studio ufficiale della Presidenza del Consiglio. Veti locali quasi sempre imposti da minoranze (superabili solo con riforma del titolo V, débat public e referendum popolari), contenziosi amministrativi creati ad arte dagli esclusi, conflitti fra governo e Regioni, conflitti fra Regioni ed enti locali, valutazioni di impatto ambientali ripetute nel tempo, progetti continuamente rivisti perché inadeguati, veti delle Sovrintendenze, pianificazione debole e incerta, conferenze di servizi senza esiti definitivi (ora riformate con qualche passo avanti), ridottissima capacità di spesa anche per lo smantellamento delle strutture tecniche della Pa, che continua ad avere un perimetro vastissimo senza presidiare le funzioni-chiave, incapace di controllare gli appaltatori per far rispettare prezzi e tempi e mettere alla porta quelle imprese che prima fanno ribassi elevatissimi e poi tentano di recuperare con riserve e varianti.
La tela di Penelope
La seconda faccia del male italiano è l’eterna riprogrammazione svolta dalla politica anziché cercare minimi comuni denominatori che diano stabilità all’azione pubblica e creino una sorta di piano nazionale condiviso. Ogni maggioranza politica ha le sue priorità e le sue project review (l’ultima l’ha fatto il centro sinistra due anni fa e ora tocca alla nuova maggioranza)e gioca le infrastrutture come terreno di scontro politico, una forza politica contro l’altra, il governo contro le Regioni, dando al proprio elettorato e togliendo a quello avversario, con il risultato - questo sì un unicum italiano - che il quadro cambia, si aggiusta, vacilla, sbanda, si azzera, riparte da capo, ma resta comunque incerto nei decenni. Senza contare che un’opera pubblica per essere realizzata ha bisogno di un orizzonte temporale più lungo di una legislatura.