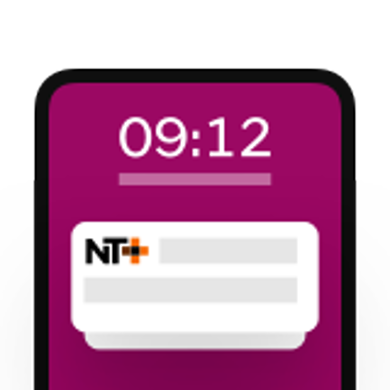Le società non sono enti pubblici: ora la riforma Madia va semplificata
A più di tre anni dall’approvazione del Testo Unico sulle partecipate, e con un clima ormai mutato nei confronti dell’intervento pubblico in economia per le grandi crisi industriali che hanno coinvolto il Paese e per alcune palesi inadeguatezze nella gestione privata delle concessioni pubbliche, è quanto mai necessario intervenire sulla disciplina delle società partecipate, riflettendo su alcune questioni di fondo.
Anzitutto va messa in discussione la scelta, semplicistica, di traslare obblighi e adempimenti propri della pubblica amministrazione alle società pubbliche. Tutto ciò ha prodotto un superfetazione di disposizioni, alcune francamente surreali, che costringono le società a sopportare irrazionali oneri aggiuntivi rispetto a quanto prescritto nella disciplina comunitaria. Si tratta della mala prassi del «gold plating», che viene stigmatizzato da tempo dalla medesima Commissione Europea (Commissione Europea, Smart regulation in the European Union, COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 2010) ma che viene largamente praticato nel nostro Paese, spesso quasi inconsapevolmente.
Eppure anche il Consiglio di Stato, nel suo parere n. 855/2016 sul decreto legislativo del Codice appalti, metteva in guardia su questo problema, ricordando che l’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11/2016 aveva stabilito, tra i principi direttivi per l’attuazione delle deleghe, proprio il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee. Considerazioni rimaste lettera morta, evidentemente.
La questione va ben al di là del Codice degli Appalti. Ed è chiaro che l’assimilazione, sotto il profilo dell’operatività, delle società a quella delle Pa indebolisce la natura di impresa di queste aziende e le sovraccarica di costi aggiuntivi, che finiscono per pesare sui cittadini e sugli standard di efficienza dei servizi. Che senso ha ipotizzare che occorra un intervento pubblico nell’economia, che in genere si rende necessario proprio a fronte dei fallimenti di mercato, se poi quando si costituisce una società pubblica ci si inventa di tutto per rendere il suo operato inutilmente gravoso?
Un’altra problematica, altra faccia della stessa questione, riguarda la possibilità concreta di intervenire con lo strumento societario e nei processi di aggregazione. Il Tusp ha posto notevoli ostacoli non solo sulla tipologia delle attività, ma perfino nel processo costitutivo delle società, addirittura per le società di secondo livello. È ragionevole pretendere che una società di ambito, a cui partecipano magari 100 Comuni, per costituire una Srl debba passare per tutti i consigli comunali degli enti soci? Ed è davvero impossibile prevedere delle norme per favorire i processi di aggregazione? È chiaro che le operazioni straordinarie, ed in particolare le fusioni, possano essere effettuate solo mediante trattative dirette e non per il tramite di procedure competitive. Il Tusp, in realtà, già lo ammette, ma forse occorre essere più espliciti, vista la resistenza della burocrazia pubblica a percorrere strade inconsuete, anche se logiche e legittime.
Al di là degli esempi, comunque, occorre riflettere su quale sia la strada per poter ricorrere allo strumento societario nel modo più efficace e semplice. Perché se azienda pubblica deve essere, e in certi casi è inevitabile che lo sia, almeno si deve essere certi che sia in condizione di operare davvero.